Vi proponiamo un estratto de «Il nuovo impero arabo. Come cambia il Medio Oriente e quale ruolo avrà nel nostro futuro», l'ultimo libro di Federico Rampini in uscita il 21 maggio, edito da Solferino
Che si tratti dell’intelligenza artificiale o della mega città avveniristica Neom, alcuni progetti della Vision 2030 del principe saudita Mohammed bin Salman (MbS) potrebbero deludere, costare troppo, incappare in incidenti di percorso, o addirittura schiantarsi in fallimenti clamorosi. È il rischio di impresa, e MbS per certi versi si comporta come un modernissimo imprenditore. Al tempo stesso è un visionario che trae legittimità da una memoria storica; il suo nuovo impero arabo potrebbe essere risucchiato verso il passato.
Prima di enumerare i limiti di questo esperimento, e ricordare ciò che potrebbe andare storto, voglio partire dal suo aspetto più positivo. È lo strappo che questo principe illuminato rappresenta rispetto alla cultura del vittimismo, di cui tanta parte del mondo arabo è prigioniera dagli anni Sessanta. Quando molti paesi arabi conquistarono la loro indipendenza dagli imperi coloniali europei, si lanciarono in piani di modernizzazione e riforme, spesso di ispirazione socialista. L’espressione «mondo arabo» a quell’epoca era più usata di oggi perché c’era maggiore sintonia e travaso di idee in quell’area molto ampia dove si parla l’arabo e si pratica la religione musulmana (tutti retaggi dell’impero coloniale fondato da Maometto). Dall’Algeria alla Giordania, dalla Siria allo Yemen, oltre alla lingua e alla fede, circolavano sogni comuni. Il più autorevole e prestigioso leader di quel mondo fu a lungo l’egiziano Nasser, paladino del «panarabismo» che mobilitò gli egiziani e tanti popoli vicini. Quei piani fallirono in maniera disastrosa, per colpa di classi dirigenti incompetenti e disoneste, scadenti e ladre.
Mentre in Estremo Oriente decollavano uno dopo l’altro i miracoli di tanti «dragoni» asiatici – che non erano solo dei boom economici bensì progressi estesi all’istruzione, alla tecnologia, all’ordine pubblico e alla sicurezza – in Nordafrica e in Medio Oriente le aspirazioni dei popoli erano frustrate. Scattò tra i leader la ricerca di un capro espiatorio e fu trovato nell’Occidente: era tutta colpa del colonialismo più recente (peraltro assai più breve rispetto al dominio ottomano). Veniva ignorato il fatto che, dall’altra parte del continente asiatico, paesi colonizzati molto più a lungo dagli occidentali erano capaci di modernizzarsi a gran velocità.

La colpevolizzazione di Israele
Il vittimismo arabo dilagava, si imponeva come dottrina ufficiale e al contempo contaminava le masse con un senso diffuso di recriminazione, rancore, de-responsabilizzazione. Alla colpevolizzazione degli occidentali si aggiunse quella di Israele. Fino agli anni Sessanta e Settanta, anche Israele aveva seguito modelli socialisti, basti pensare ai kibbutz. Il vero boom – economico e tecnologico – si verifica quando Israele abbraccia una ricetta capitalistica, a partire dagli anni Ottanta: diventa una piccola superpotenza, con livelli scientifici e di benessere che lo distanziano sempre più dai suoi vicini.
Quel successo attira su di sé l’invidia generale dei vicini falliti. Sempre all’insegna del vittimismo e dello «scaricabarile», gran parte del mondo arabo si autoconvince che la ricchezza di Israele può avere una sola spiegazione: è costruita sullo sfruttamento e sull’oppressione dei palestinesi. È un falso clamoroso, eppure diventa un luogo comune così tenace da radicarsi nel tempo come dottrina ufficiale anche nei campus universitari dell’Occidente. Anziché studiare nei dettagli il progresso di Israele per emularne le ricette vincenti (cosa che, per esempio, in Estremo Oriente la Cina ha fatto copiando i miracoli di Giappone, Singapore, Taiwan, Corea del Sud), la maggior parte dei dirigenti arabi hanno investito sull’antisemitismo come collante ideologico per nascondere le proprie incapacità e malefatte.
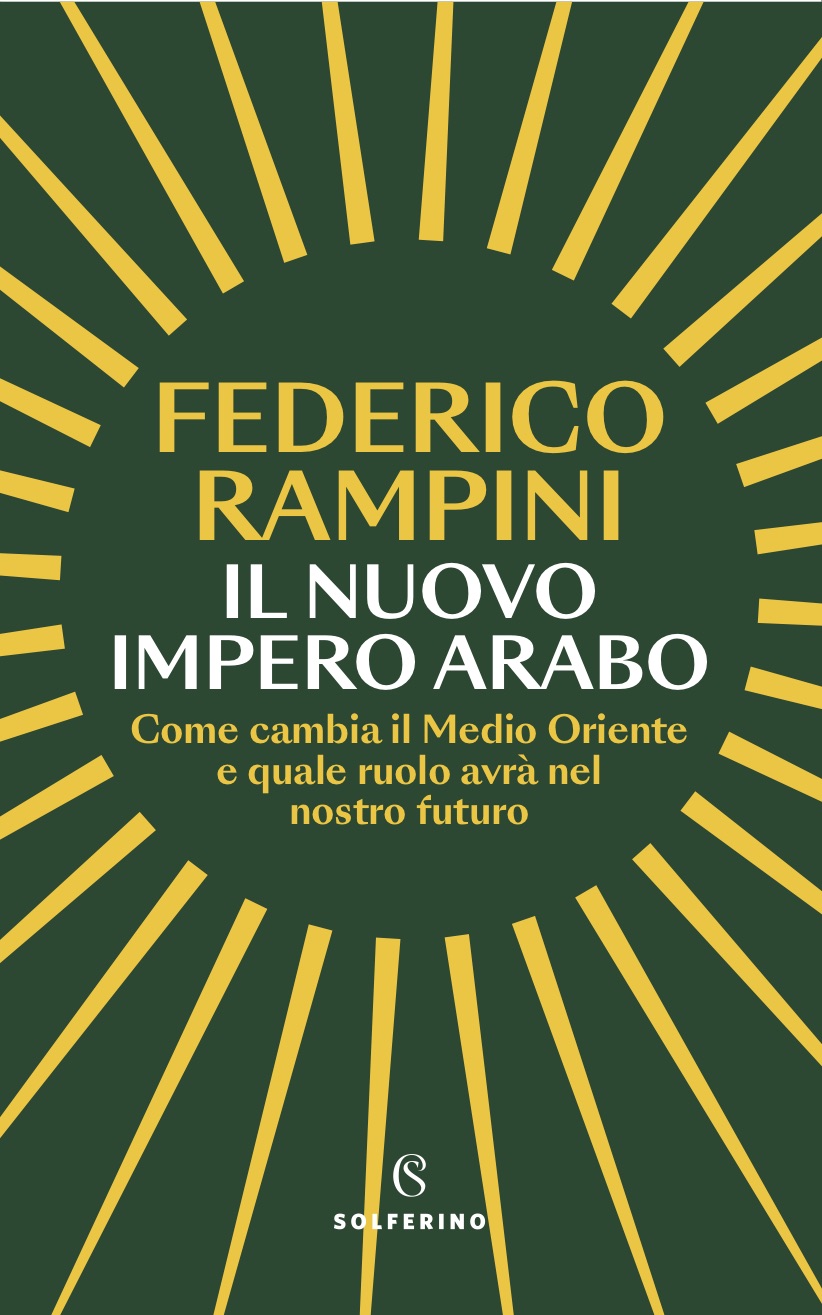
Perché Mbs ha segnato una svolta
Ecco: il Kingdom of Saudi Arabia (Ksa) di MbS – preceduto dai laboratori di Dubai e del Qatar – rappresenta una formidabile rottura con tutto ciò. Il principe ha dismesso la cultura dell’invidia: Israele lo attira per quello che è riuscito a fare, per la valorizzazione dei talenti innovativi, per lo spirito imprenditoriale. MbS rinuncia alla grottesca caricatura che descrive il successo israeliano come una rapina dei poveri vicini. Il moralismo in voga in alcuni ambienti italiani reagisce con riflessi automatici, tanto conformisti quanto inintelligenti: così come la parola «saudita» fa scattare l’orrore obbligatorio per i «cattivi petrolieri», allo stesso modo l’avvicinamento degli anni scorsi tra Arabia e Israele è stato disprezzato come «bieco affarismo». Ben venga l’affarismo se è l’alternativa alla guerra. Fossero stati degli affaristi i leader di Hamas, con i fiumi di miliardi ricevuti per anni avrebbero trasformato Gaza in una piccola Dubai.
Se l’esperimento saudita andrà avanti lungo questa strada, sarà una novità fantastica che a lungo termine potrebbe avere ripercussioni mondiali. La cultura del vittimismo e del rancore ha generato odio per l’Occidente, un odio che a sua volta ha contributo alla diffusione del jihadismo islamico, della violenza. La spirale del fanatismo ha continuato a mantenere nell’ignoranza retrograda e reazionaria una parte rilevante del mondo musulmano, e questo veleno si è infiltrato in tante comunità di immigrati islamici che odiano l’Occidente nonostante vi siano stati accolti a braccia aperte, e con molti più diritti di quanti ne avevano a casa loro.
La rinuncia al vittimismo da parte di MbS è una delle ragioni fondamentali per cui noi occidentali dobbiamo sperare che lui ce la faccia. L’altra ragione è che ha finalmente chiuso i rubinetti dei petrodollari che finanziavano madrase fondamentaliste nel mondo intero, Europa inclusa. L’Arabia della Vision 2030 sta muovendo i primi passi per conquistarsi un soft power, o egemonia culturale di tipo diverso, non più fondata sul fanatismo religioso e sull’intolleranza. Nei nuovi equilibri della geopolitica mondiale, il Kingdom of Saudi Arabia è uno dei protagonisti del Grande Sud globale perché, per esempio, investe nelle energie rinnovabili anche in Africa. Se la sfida di MbS sarà vincente, le comunità di immigrati musulmani di seconda e terza generazione in Italia o in Francia, in Germania o in Svezia, avranno finalmente un modello alternativo rispetto alla cultura della recriminazione, alla perenne ricerca di vendette e risarcimenti per i presunti danni subiti dall’Occidente.
Probabilmente non è un caso che a proporre una narrazione diversa, post-vittimista, sia l’unico grande paese del mondo arabo a non essere mai stato una colonia dell’Occidente: il Ksa, prima di nascere nella sua versione contemporanea, era stato dominato dall’impero ottomano, mentre con inglesi e americani aveva negoziato alleanze e protezioni per liberarsi dai turchi.
Cosa potrebbe andare storto? Per consolidare il suo potere e lanciare il Ksa a gran velocità verso il futuro, MbS ha stravolto equilibri antichi e ha calpestato regole sacre, o presunte tali. Dai tempi di suo nonno Abdul Aziz, fondatore della dinastia che regnò dal 1932 al 1953, il Regno poggiava su cinque grandi constituency o corpi sociali: al primo posto la stessa famiglia reale, un ibrido tra una dinastia capitalistica e un partito politico fondato su parentele e principi ereditari; al secondo posto il clero wahhabita; al terzo posto i notabili etnici che tuttora vengono chiamati capi tribù, retaggio dell’epoca in cui re Abdul Aziz «confederò» con la forza o con l’astuzia i clan dei nomadi del deserto; al quarto posto la categoria dei mercanti, i cui antenati furono protocapitalisti che prosperavano tra Golfo arabico-persico e Mar Rosso lungo le Vie dell’Incenso e della Seta; infine, una quinta categoria molto più recente ma non irrilevante è quella dei tecnocrati, spesso educati dallo Zio Sam nelle compagnie petrolifere o nelle università o nelle accademie militari americane. Il confine tra questi cinque gruppi non è preciso e immutabile. Ci sono sauditi che hanno identità multiple, appartengono a due o più di queste constituency.
Fino all’avvento di MbS, per molti decenni il potere della famiglia Saud aveva cercato di non scontentare nessuna di quelle cinque super lobby: aveva applicato al paese una direzione di tipo collegiale e aveva gestito le successioni dinastiche rispettando le gerarchie anagrafiche, cioè il principio di anzianità. Con MbS è saltato tutto, il «giovanotto» governa per strappi e accelerazioni, ha concentrato su di sé un potere enorme; ha messo da parte illustrissimi parenti più anziani di lui; ha impoverito alcune constituency con i suoi blitz anti-corruzione.
Ho usato più volte il paragone con la Cina, pur precisando le enormi differenze. Eccone un’altra. Nella lotta alla corruzione che ha reso Xi Jinping altrettanto popolare tra i cinesi di quanto MbS lo sia nel popolo saudita, il leader di Pechino ha potuto contare su quella «macchina da guerra» che è il Partito comunista: cioè un’organizzazione capillare, strutturata, gerarchica, cementata da un’ideologia, e che fece le sue prime prove nella lotta di liberazione contro i giapponesi negli anni Trenta. MbS non ha a sua disposizione un apparato neppure lontanamente paragonabile.
Nel corso del mio viaggio in Arabia, l’impressione che ho avuto è che il principe goda di un consenso elevato, è indubbio, ma questa è una fotografia della situazione nel 2024 e non garantisce che tale consenso sopravviva in futuro se alcuni suoi progetti affondano. Oppure che a un certo punto alcune constituency danneggiate dalle azioni di MbS non si coalizzino per rovesciarlo. Più ancora dell’orrore suscitato dal feroce assassinio del giornalista Khashoggi, che rimane come una macchia incancellabile nell’immagine internazionale di MbS, all’interno del paese pesa il «sequestro di parenti e miliardari» all’hotel Ritz-Carlton di Riad: da un lato ha terrorizzato i suoi potenziali rivali, dall’altro può avere seminato i germi di vendette future.
Quel blitz anti-corruzione realizzato con metodi di stampo mafioso conferma un altro limite di MbS.
Verso il progresso, ma con metodi autoritari
Per spiegarlo mi ispiro a un capolavoro letterario. Tutti ci siamo imbattuti prima o poi nelle Mille e una notte, tesoro della cultura araba (anche se impregnato di influenze indiane e persiane). Leggendo le storie di Aladino, Alibabà e i quaranta ladroni, Sinbad il marinaio, abbiamo colto soprattutto la fantasia meravigliosa, il carattere fiabesco, il fascino dell’Oriente. Mi ha colpito, al confronto, la versione contemporanea che ne ha dato il grande scrittore egiziano Nagib Mahfuz. Premio Nobel per la letteratura nel 1988, Mahfuz ha reinventato a modo suo le fiabe classiche della tradizione araba in un capolavoro del 1982. In italiano è intitolato Notti delle mille e una notte e pubblicato da Feltrinelli. Più dell’aspetto magico e favoloso, nella storia di Mahfuz prevale un’atmosfera oppressiva e cupa, dominata dal dispotismo imprevedibile e crudele del sultano.
Nelle Mille e una notte originarie, il fatto che Sheherazade inventi ogni sera delle trame avvincenti che creano l’attesa di un seguito (le serie televisive odierne non hanno fatto che copiarla…) è un geniale espediente narrativo; quasi dimentichiamo che è la condizione per la sua sopravvivenza, affinché la stessa Sheherazade non venga condannata a morte dal sultano. Nell’opera del Premio Nobel, invece, la minaccia di gesti arbitrari e feroci del sultano diventa il tema principale. Questo la dice lunga su quanto il dispotismo e l’abuso d’autorità condizionino la società civile nel mondo arabo contemporaneo. Il limite di MbS, ossia la scorciatoia verso il progresso imposta dall’alto con metodi autoritari, può conciliarsi con la capacità d’innovazione di cui l’Arabia ha bisogno? Riaffiora anche qui un possibile parallelismo con la Cina, dove Xi Jinping ha imposto una sterzata centralista, dirigista e statalista, che alla lunga potrebbe penalizzare la creatività imprenditoriale del suo popolo.
Sul futuro di MbS incombe la celebre «profezia» di Ibn Khaldun, il più grande storico arabo di tutti i tempi, vissuto in un’età dell’oro per la sua civiltà (nacque a Tunisi nel 1332, morì al Cairo nel 1406). Tra i tanti affreschi storici sui cicli imperiali, Ibn Khaldun formulò anche una sua legge secondo cui le dinastie reali arabe durano centocinquant’anni oppure tre generazioni al massimo, poi si sfasciano nelle convulsioni di guerre civili, rivolte o lotte per la successione. Con MbS siamo arrivati alla terza generazione della casata dei Saud…
21 maggio 2024
© RIPRODUZIONE RISERVATA






