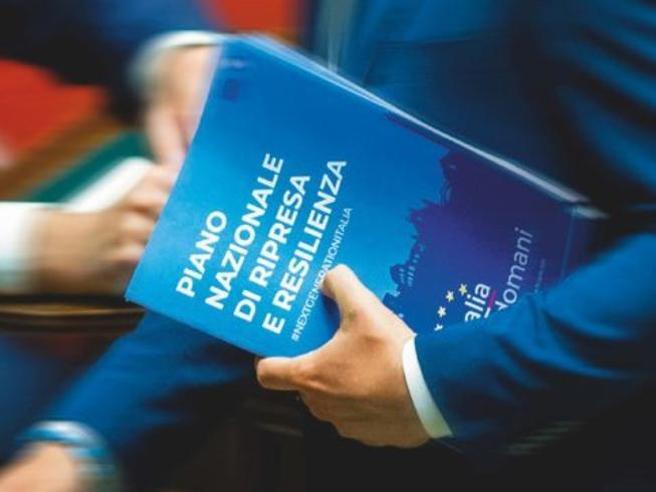Il Recovery Fund dell’Europa sta fallendo? Il caso del Belgio (e l’isola della Principessa Elisabetta)
«Come simbolo delle ambizioni dell’Europa l’Isola della Principessa Elisabetta è difficile da battere». Comincia così un’ampia ricostruzione del Financial Times nella sua versione online che fustiga la capacità dell’Europa di usare al meglio i fondi del Pnrr, quel meccanismo di mutuo soccorso tra Paesi - di cui l’Italia ha finito per giovarne per 209 miliardi di euro (con una parte a fondo perduto) - nato per superare l’emergenza Covid. «È improbabile che la piattaforma di cemento al largo delle coste del Belgio vinca premi per la bellezza. Ma il progetto, presentato come la prima isola energetica artificiale al mondo, è silenziosamente rivoluzionario: un hub energetico progettato per collegare i parchi eolici offshore nel Mare del Nord alla rete elettrica del Belgio e, un giorno, fornire energia pulita in tutto il Continente. Prende il nome dalla futura regina del Belgio, è un pezzo di infrastruttura energetica che soddisfa le aspirazioni dell’Unione Europea di innovare e investire in un futuro più verde, con il sostegno dell’esclusivo fondo di ripresa post-pandemia. Tuttavia i finanziamenti provenienti da Bruxelles sono ostacolati da una disputa tra Belgio e UE sulla riforma delle pensioni, che fa dell’Isola della Principessa Elisabetta un emblema non solo delle ambizioni dell’Europa ma anche dei problemi burocratici e logistici che stanno ostacolando il suo fondo limitando le possibilità di finanziamento», scrive il quotidiano finanziario della City.
La ratio del fondo
Il fondo Next Generation EU, che comprende il Recovery and Resilience Facility, è stato concordato nel 2020 ma è entrato in vigore nel febbraio 2021 al culmine della pandemia di Covid-19. Gli Stati membri hanno concordato all’unanimità di sottoscrivere congiuntamente 800 miliardi di euro di debito per raggiungere due obiettivi generali: far uscire le loro economie in difficoltà dalla recessione indotta dal lockdown e investire in priorità condivise come il cambiamento climatico e la digitalizzazione per favorire una crescita sostenibile. In Italia, come ha ricostruito puntualmente Federico Fubini sul Corriere della Sera, è un mistero quello che sta avvenendo sul lato dell’utilizzo delle risorse.
LEGGI ANCHE
Clima, i danni dei cambiamenti hanno superato in 40 anni i fondi del Pnrr
Rai, Ferrovie, Inps, Inail: in arrivo 500 nomine nel settore pubblico
Scontro tra Regione e cliniche sui 75 milioni di Ristori erogati per il Covid
Pnrr, nuova stima per il Trentino: quasi mezzo miliardo ai privati
Pnrr, intesa nel governo sulla revisione: regia accentrata, trovati 13 miliardi su 17
Fitto ora prova a sminare la protesta cavalcata da De Luca e convoca i sindaci campani a Roma
Il cronoprogramma e le riforme
Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue, lo ha più volte descritto come un’opportunità unica «per investire in una ripresa collettiva e in un futuro comune». Ma i fondi sono arrivati con un meccanismo farraginoso, da conto alla rovescia. Raggiungere un accordo per emettere debito comune su una scala senza precedenti era possibile solo sulla premessa che il fondo sarebbe stato un esperimento una tantum, limitato nel tempo, che si sarebbe concluso nel 2026. Il primo obiettivo è stato, sotto molti aspetti, un successo. L’accordo, insieme a un programma di acquisto di obbligazioni di emergenza da parte della Banca Centrale Europea e all’allentamento delle regole sulla spesa e sugli aiuti di Stato, ha avuto un immediato effetto tranquillizante sui mercati, evitando un tracollo economico. Di conseguenza, l’UE ha raggiunto i livelli di crescita pre-pandemia in meno di due anni.
Il rimbalzo del primo anno
Nel 2022 l’Europa è cresciuta più rapidamente di Stati Uniti e Cina e i maggiori beneficiari del fondo, Italia e Spagna, hanno sovraperformato la media dell’UE. Secondo la Commissione, il rapporto tra investimenti pubblici e prodotto interno lordo è aumentato a livello aggregato dal 3% nel 2019 al 3,2% nel 2022. Ma ora l’obiettivo di alimentare la crescita futura sembra sempre meno probabile da raggiungere. L’attuazione è in ritardo: i disaccordi tra le capitali e Bruxelles sulle riforme hanno ritardato i pagamenti e gli investimenti sono stati ritardati o ridimensionati a causa dell’inflazione. Ad oggi è stato erogato solo un terzo dei fondi. Già nel 2020 la Commissione stimava che il sostegno alla ripresa avrebbe aggiunto in media l’1,9% al Pil nel 2022. Ma l’incremento è stato molto inferiore, pari allo 0,4%, secondo un rapporto della Commissione che sarà pubblicato mercoledì.
L’analisi di Goldman Sachs
L’analisi di Goldman Sachs suggerisce che, per le quattro principali economie dell’UE – Germania, Francia, Italia e Spagna – l’impatto sulla produzione delle sovvenzioni per la ripresa è nell’ordine dei decimali e diventerà negativo man mano che il fondo si ridurrà. La sfida sarebbe quella di trasformare l’impatto immediato in livelli di crescita permanentemente più elevati. La misura in cui i fondi potranno essere sbloccati determinerà probabilmente se il finanziamento comune dell’UE sarà un esperimento una tantum, come sperano alcuni Stati membri, o se diventerà uno strumento che secondo i suoi sostenitori garantirà il posto dell’Europa tra le principali economie mondiali. Negli ultimi anni, il motore economico dell’Europa non è riuscito a tenere il passo con quello della Cina e degli Stati Uniti. L’Inflation Reduction Act dell’amministrazione Biden, approvato dopo il fondo Next Generation EU, consente investimenti da 386 miliardi di dollari nel cambiamento climatico e nella decarbonizzazione, principalmente attraverso crediti d’imposta e ha alimentato una corsa globale ai sussidi. Il fondo per la ripresa aveva lo scopo di dare all’Europa i mezzi per tenere il passo in quel contesto, ma alcuni mettono in dubbio questo desiderio.
La struttura del Pnrr
Una forte criticità risiede nella struttura del fondo. I Paesi ricevono miliardi in sovvenzioni e prestiti solo se raggiungono gli obiettivi di riforma e investimento – negoziati con l’UE – che vanno dal potenziamento delle infrastrutture pubbliche alla revisione dei sistemi pensionistici, con i più colpiti dalla pandemia che ne trarranno i maggiori benefici. I pagamenti condizionati si sono rivelati efficaci nell’ottenere cambiamenti politici a lungo ritardati, come una revisione della pubblica amministrazione in Italia e del mercato del lavoro in Spagna. La Commissione europea calcola che la percentuale di riforme raccomandate da Bruxelles e adottate dai paesi dell’UE è aumentata dal 52% nel 2021 al 69% nel 2023 quando il fondo ha iniziato ad essere implementato. Ma in altri casi, compreso quello del Belgio, le riforme si sono rivelate un ostacolo e hanno ritardato i pagamenti. Lo scorso luglio il governo belga ha accettato di apportare modifiche al proprio sistema pensionistico per aprire la strada allo sblocco di fondi che sarebbero destinati a progetti tra cui «l’Isola Principessa Elisabetta». Ma la Commissione critica la riforma perché non ridurrebbe il peso delle pensioni sulle finanze pubbliche. Mentre il dibattito prosegue la data di scadenza del fondo si avvicina sempre di più e non esiste ancora un piano concreto per ciò che potrebbe accadere dopo.
Iscriviti alle newsletter di L'Economia
 Whatever it Takes di Federico Fubini
Whatever it Takes di Federico Fubini
Le sfide per l’economia e i mercati in un mondo instabile
 Europe Matters di Francesca Basso e Viviana Mazza
Europe Matters di Francesca Basso e Viviana Mazza
L’Europa, gli Stati Uniti e l’Italia che contano, con le innovazioni e le decisioni importanti, ma anche le piccole storie di rilievo
 One More Thing di Massimo Sideri
One More Thing di Massimo Sideri
Dal mondo della scienza e dell’innovazione tecnologica le notizie che ci cambiano la vita (più di quanto crediamo)
E non dimenticare le newsletter
L'Economia Opinioni e L'Economia Ore 18