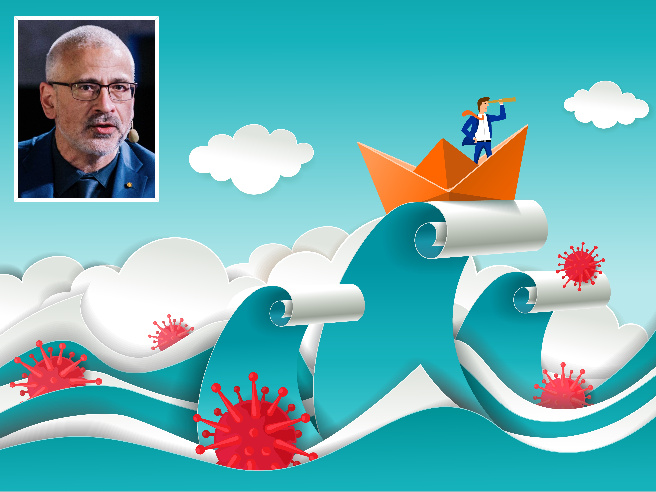Aviaria, Covid e altre pandemie. Vespignani: «Così AI e Big Data aiutano a predire le prossime»
L’influenza H5N1 aviaria negli Usa trasmessa ai bovini è solo l’ultima delle potenziali sfide. L’intelligenza artificiale sta affinando previsioni e comprensione sul come, il dove e il quando delle minacce epidemiche
«Come spesso ribadiamo nel nostro campo, non è questione di “se” ma di “quando” ci sarà la prossima pandemia. Recentemente, negli Usa, si è verificata l’espansione dell’influenza aviaria H5N1 ai bovini, ma la lista delle potenziali minacce è lunga. Le pandemie hanno segnato la storia dell’umanità e continueranno a farlo. Le troveremo anche nel futuro. Meglio farci trovare preparati». È il consiglio di Alessandro Vespignani , tra i massimi esperti di epidemiologia computazionale a livello internazionale (si veda a lato).
Le sue ricerche si concentrano sullo sviluppo di modelli per prevedere la diffusione delle malattie infettive e comprenderne la dinamica nella società. Questi modelli vengono usati per simulare scenari di diffusione delle malattie su scala globale o nazionale integrando dati demografici e di mobilità per prevedere il come, il dove e il quando delle minacce epidemiologiche.
«Professor Vespignani il grande pubblico ha imparato a conoscerla durante la pandemia di Covid-19: preparazione e risposta alle pandemie sono migliorate»?
«Durante la pandemia abbiamo fatto progressi significativi: dal sequenziamento su grande scala dei virus e la mappatura della mobilità delle popolazioni, sino agli algoritmi previsionali più avanzati e le preziose esperienze su come comunicare e prendere decisioni. Tuttavia, restano numerose sfide da affrontare. Da un lato possiamo accedere in tempo reale ai dati sulla mobilità di milioni di persone, dall’altro i dati delle realtà sanitarie locali spesso arrivano in ritardo e non sono facilmente accessibili. È necessario sviluppare metodologie per comprendere meglio gli effetti spesso asimmetrici delle malattie e degli interventi su differenti strati sociali, evidenziandone le disuguaglianze osservate.
«Dobbiamo trasformare in strutture permanenti le iniziative avviate durante la pandemia, come i Centri nazionali per le previsioni e l’analisi. Negli Usa, ad esempio, il governo federale ha lanciato la rete nazionale di laboratori Insight che, con ingenti finanziamenti, moltiplica le capacità analitiche del Paese attraverso l’uso di machine learning, intelligenza artificiale e con le migliori tecnologie disponibili».
Come usate i modelli computazionali per prevedere la diffusione delle infezioni?
«Il nostro lavoro come scienziati non sostituisce quello dei medici, operatori sanitari e volontari, veri eroi di ogni epidemia. Portiamo avanti una battaglia diversa, basata su numeri e informazioni per fornire ai decisori e al sistema sanitario le strategie migliori per anticipare e combattere l’agente patogeno. L’epidemiologia computazionale è un’arma aggiuntiva che, dalle retrovie, genera le informazioni cruciali per comprendere e anticipare un nemico spesso invisibile e sconosciuto, che si diffonde attraverso i nostri comportamenti e interazioni».
In che modo AI e Big Data entrano in gioco?
«L’integrazione di AI e Big Data nell’epidemiologia migliora l’analisi di grandi volumi di dati in tempo reale, affinando le previsioni e la comprensione delle dinamiche di trasmissione delle malattie. Strumenti come la sorveglianza epidemiologica su piattaforme partecipative, Influweb in Italia e Influenzanet in Europa, coordinate dai ricercatori di Isi Foundation, l’utilizzo di dati da social network e la sorveglianza genomica su grande scala, rivoluzionano la ricerca in questo campo, permettendo nuovi modi di raccogliere dati e trasformarli in conoscenza».
Qual è il ruolo della ricerca nella formulazione di politiche pubbliche e nella gestione delle emergenze sanitarie?
«Utilizzando numeri, dati e modelli, analizziamo che cosa accade all’epicentro dell’epidemia, gli effetti degli interventi di mitigazione e i segnali di una possibile diffusione. Man mano che conosciamo meglio il patogeno, ci focalizziamo sul disegnare strategie per contrastarlo, elaborando previsioni e scenari. Questi non solo suonano l’allarme per i decisori, ma producono informazioni sull’efficacia delle misure di contenimento e stimano l’impatto dei nostri comportamenti sulla traiettoria dell’epidemia. Tutti elementi fondamentali nel processo decisionale di contrasto alle emergenze sanitarie».
Quali competenze tecniche e organizzative servono per affrontare efficacemente le prossime pandemie?
«Dobbiamo introdurre un approccio multidisciplinare attraverso l’integrazione della tecnologia all’interno dei paradigmi e delle pratiche di salute pubblica — dice Vespignani — . Ogni epidemia è una storia a sé. La risposta migliore a una emergenza sanitaria è quella capace di adattarsi velocemente al nemico di turno. Ciò può avvenire solo attraverso un processo di pianificazione ed esercizio costante che va fatto prima delle emergenze. Attraverso la definizione di centri di risposta pandemica, infrastrutture, laboratori in grado di attivarsi velocemente. E di tanta ricerca scientifica. Non possiamo ricordarci del bisogno di scienza solo quando abbiamo un problema. Il “sistema ricerca” non viene creato in un giorno. La conoscenza non viene trasferita e resa operativa a comando».
Il governo ha varato il Piano Pandemico Nazionale 2024-2028: funzionerà?
«Il nuovo piano pandemico amplia lo spettro delle possibili minacce con potenziale pandemico, delineando non solo gli strumenti di intervento possibili, ma anche le strutture e i modi per il coordinamento dell’emergenza a livello nazionale e locale. Questo piano rafforza metodi e strategie già testati, e sottolinea l’importanza del coordinamento e delle tempistiche di attuazione. In questo contesto, diventa centrale dotarsi di quei centri per la previsione e l’analisi del rischio epidemiologico, distribuiti sul territorio nazionale e supportati dalle tecnologie computazionali più avanzate e dall’intelligenza artificiale che possono fare la differenza. I piani pandemici sono documenti, ma spetta ai governi di tradurli in risorse e infrastrutture che siano pronti nel caso di emergenza. Altrimenti sono solo fogli in un cassetto».